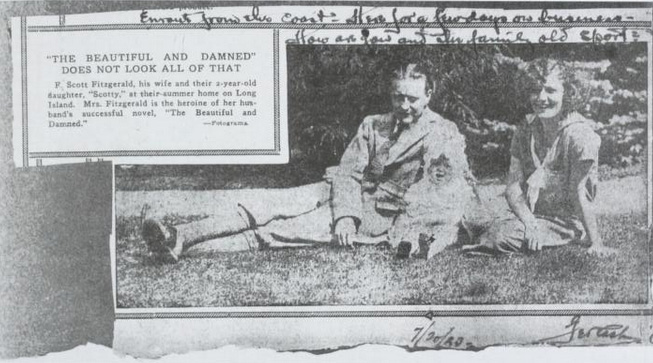Il Fediverso (visto da un’esploratrice in fuga)
Stretta all’angolo da @xab, che ha scelto la tematica, e considerato l’interessante, esaustivo post scritto da @77nn, ammetto che non c’è gara… e… un momento… il bello del Fediverso è proprio questo!
Se a scrivere questo post fosse stata LaVi di una ventina di anni fa, l’avrebbe fatto sentendosi spaccata a metà, divisa tra ciò che voleva comunicare e ciò che avrebbe con buona probabilità fatto presa sui lettori. È questo che mi ha insegnato il giornalismo, è questo che ho portato con me nel blog quando le regole dell’editoria – o idioteria, come avevo cominciato a chiamarla – avevano iniziato a starmi strette, motivando il mio addio a quel mondo. I giornali campano di pubblicità, la pubblicità dev’essere vista, quindi servono lettori, e i lettori se non ci sono te li devi andare a catturare, se vuoi uno stipendio a fine mese. Punto. Il come è una questione etica, che non interessa all’editore e ai proprietari dei giornali più di quanto li interessi discutere di astrofisica o del sesso degli angeli. Il come non viene discusso nelle riunioni di redazione né men che meno nelle sedute del consiglio d’amministrazione. Il blog, allora, mi era sembrato una boccata d’aria fresca: potevo scrivere ciò che volevo, come volevo, senza dover compiacere sponsor più o meno velatamente, senza dover spacciare menzogne per verità, senza cesellare ogni singola frase affinché potesse portare un lettore in più nelle casse del giornale. Ci misi un po’ per accorgermi che, però, il meccanismo sotteso era lo stesso: certo, la grande G ti dava spazio gratis, però si prendeva i tuoi dati e, se volevi far soldi, la strada era sempre la stessa di prima. Anzi, peggio ancora. Perché senza un editore alle spalle, farsi notare è davvero difficile. Soprattutto in un mondo sterminato come quello del web, dove potenzialmente chiunque può scrivere qualunque cosa su qualsivoglia argomento. E allora i social. Ti iscrivi per creare una vetrina dove esporre ciò che fai, finisci fagocitato dal sistema. Pubblica, così rimani in cima alla lista. Pubblica, così vieni notata. Pubblica, così l’algoritmo ti premia. Pubblica, fino a quando non importa più cosa, basta esserci. In un carosello di vanità – sia come pavoneggiarsi, sia come vanus, inutile – senza fine.
E poi arrivi a un punto. A quel punto. Quello in cui ti fermi un attimo, perché qualcosa di non ben definito ha fermato per un attimo il vorticare della giostra, e ti domandi se quella roba lì, quell’ammasso di scritti e foto e notizie e informazioni che hai accumulato e dato in pasto a chiunque nel mondo, corrisponda davvero a te. E se la risposta è no, allora la tentazione di mandare tutto all’aria è davvero forte. E lo stesso avviene se qualcuno decide, ancora una volta, di mettere le mani su ciò che scrivi e di modificarlo o usarlo per i propri scopi. A me era successo nell’editoria, prima, e poi quando Musk pareva intenzionato ad acquistare Twitter – cosa che poi avvenne. Fu in quel momento che migrai nel Fediverso, approdando su Mastodon. E il mio primo barrito ottenne più risposte di quante ne avessero ottenuti cinguettii reiterati. C’erano persone (nel mio caso Alberto, Fabio e Gustavino) dietro gli schermi e le tastiere, persone vere con cui dialogare, non numeri da conquistare. Altra buona notizia: Mastodon non è il Fediverso, Mastodon è un pezzo – significativo, certo, parecchio vivace e popoloso, ma pur sempre un pezzo – del Fediverso.

C’è, letteralmente, un intero universo da esplorare, qui. Un universo i cui pianeti, satelliti, stelle e meteore sono server indipendenti, ma che comunicano tra loro grazie a una specie di lingua franca che si chiama ActivityPub. Cosa comporta questo? Tre cose innanzitutto: uno, che nessuno potrà comprare il Fediverso. Un qualsiasi multimilionario a caso potrebbe voler comprare Mastodon, ad esempio, proprio come è stato comprato Twitter, ma non gli converrebbe, semplicemente perché gli utenti si sposterebbero su un diverso server del Fediverso, lasciando Mastodon arido e disabitato, ciascuno portandosi dietro il proprio seguito proprio grazie a questa lingua franca che consente la migrazione… di pianeta in pianeta. Due, la lingua franca rende possibile la condivisione di contenuti su tutti i pianeti del Fediverso, quindi se io pubblico una foto su Pixelfed – che è una sorta di Instagram, ma rispettoso della privacy e senza algoritmi da nevrosi – chi mi segue da un altro pianeta, diciamo Mastodon per farla semplice, potrà vederla, commentarla, condividerla. E se scrivo un post sul mio blog Writefreely… eh, già! Tre, i diversi pianeti, pur essendo federati, restano indipendenti. Il che significa che ciascuno ha le proprie leggi (le regole del server), i propri abitanti (le persone iscritte a quella specifica istanza), la propria storia e le proprie tradizioni (gli argomenti preferiti e predominanti), ma in genere sono tutti molto ben disposti verso i turisti e persino verso i richiedenti asilo, come la sottoscritta allorché fuggì da Twitter.