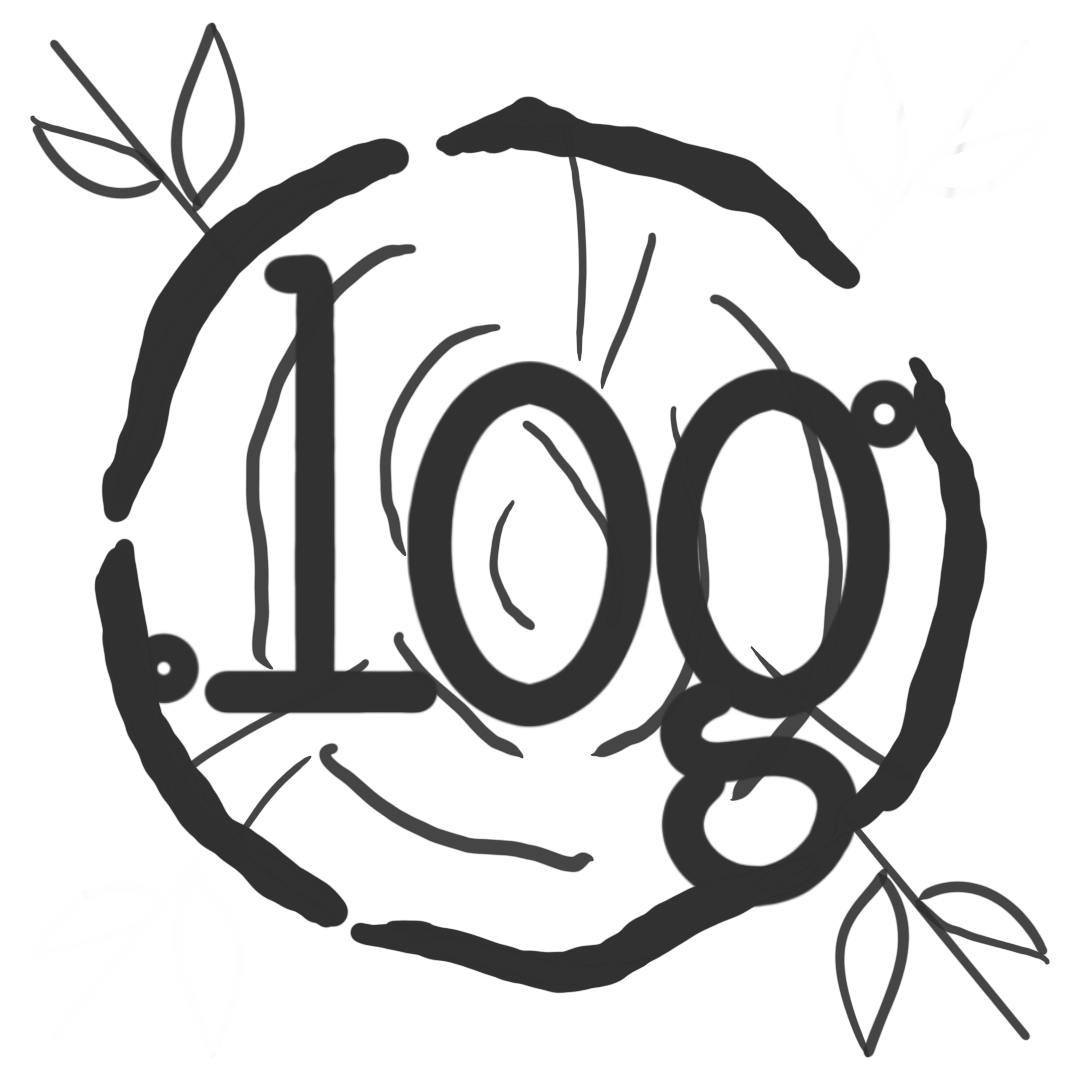Se non l'avete ancora notato, questo mio blog è ospitato sul server Livello Segreto, un “nodo” italofono di una rete di siti web indipendenti che se ne stanno al di fuori dell'Internet controllato dalle grandi aziende. Questo mese il nostro amministratore tecnico Edoardo il Casoncello ha lanciato l'idea di una Sagra Indie Web in cui i siti interessati danno contributi sul tema dell'accountability. Questo articolo è il mio contributo: è l'esatto opposto di un intervento puntuale, è un testo divulgativo semi-narrativo che, spero, risulti innanzitutto intrattenente, e in seconda battuta vi metta nel cervello del carburante per ragionare sul tema proposto da Ed.
Ante Scriptum: sì alla fin fine ho terminato questo pezzo che già era febbraio. Fottesega, tutte le fregnacce sulla vita lenta si applicano anche così.
Un processo fra le macerie
Vi racconterò una storia: non l'ho inventata io, è la mia versione di una storia che si racconta da quasi due millenni e mezzo.
Siamo nel 399 a.C. ad Atene, ma non è l'Atene che avete tutti in mente: l'Atene dei templi e delle sculture di marmo, delle bevute di vino rosso al suono delle cetra, dei festival teatrali che inizavano all'alba e finivano al tramonto per quattro o cinque giorni di seguito; l'Atene crocevia culturale, in cui tutti gli artisti e gli intellettuali greci dovevano passare se speravano di diventare qualcuno (sì tipo la Milano di oggi, purtroppo); l'Atene laboratorio politico dove era stata inventata la democrazia diretta e le decisioni le prendevano votando tutti gli uomini liberi (sottolineiamo: uomini, liberi. Niente schiavi, e le donne tutte in casa). Ecco, non è quell'Atene.
Quella che pensate voi era l'Atene del 450 a.C. circa: l'Atene che aveva insediato (con le buone o le cattive) governi amici in tutte le altre città greche affacciate sul mar Egeo, e in tal modo controllava tutti i commerci da Cipro alla Sicilia, e ogni anno spillava alle città “alleate” argento sonante con cui costruire i templi, finanziare le sagre teatrali, e assicurare agli uomini liberi poveri un misto di salario minimo garantito (ebbene sì!) e di impieghi statali (ebbene sì bis!), così che potessero partecipare alle assemblee di governo tanto quanto i ricchi.
Quell'Atene di ricchezza e benessere è morta: si è suicidata combattendo e perdendo una guerra di trent'anni contro Sparta, l'altra grande città greca, che invece è proprio la Sparta che vi immaginate: un'oligarchia totalitaria in cui tutti gli uomini delle famiglie libere sono irreggimentati nell'esercito, tutte le donne delle famiglie libere devono sfornare figli per rimpolpare l'esercito, e l'esercito deve regolarmente assaltare e terrorizzare le enormi masse di schiavi (e, talvolta, le città “alleate”) che tengono in piedi l'economia, garantendo ai cittadini liberi un tenore di vita decente senza alzare un dito. Anno dopo anno, battaglia dopo battaglia, gli Ateniesi si sono bruciati tutti i propri migliori generali, fra morti sul campo e faide interne, e hanno perso il controllo di tutti i propri “alleati”, a furia di spremerli come limoni e mandarli a morire in operazioni già perse, così che un bel giorno Atene si è svegliata piena di case spopolate, di fosse comuni fresche, e con le sue Lunghe Mura demolite dai soldati spartani al suono festoso dei flauti. Già che c'erano, gli Spartani hanno anche messo al potere trenta collaborazionisti ateniesi, tutti più che felici di cancellare il sistema democratico e importare il metodo spartano, e costoro in neanche un anno hanno allegramente fatto strage di chiunque non gli andasse a genio, meglio se persone ricche cui confiscare il patrimonio; la situazione si era fatta così calda che, a una certa, un gruppo di nazionalisti democratici si è rivoltato contro i Trenta Tiranni ed è riuscito a farli fuori... non prima che costoro cercassero di allestire una fortezza di emergenza nella cittadina di Eleusi, sobborgo di Atene, e per l'occasione massacrassero tutti gli Eleusini.
Per cui, siamo nell'Atene del 399 a.C., una città che esce da trent'anni di guerra internazionale e di guerra civile, in cui intere famiglie non esistono più, i vicini di casa si sono sgozzati a vicenda, e l'indipendenza appena ripristinata, in ogni caso, deve sottostare alla mano di ferro dell'egemone spartano. Ed è in questa città, già signora del mar Egeo, ora borgo di fantasmi, che è nato il nostro protagonista.
Storia comune di Greci particolari
Si chiama Socrate, figlio di Sofronisco, del distretto di Alopece, e ha settant'anni; è sposato con Santippe, più giovane di almeno vent'anni, e da lei ha avuto tre figli, Menesseno Sofronisco e Lamprocle. Socrate quasi certamente faceva lo scultore, come suo padre prima di lui, e durante la guerra era benestante: ha combattuto nella fanteria pesante pagandosi da solo lancia e corazza, non come i pezzenti che diventavano marinai della marina militare, stipendiati dallo Stato. Ma a un certo momento, dopo il congedo, Socrate è uscito di testa: ha smesso di lavorare, è diventato quasi nullatenente, e si è messo a gironzolare tutto il tempo su e giù per Atene, in piazza nei templi nelle palestre sotto i portici su in città alta giù al porto. E dovunque va, attacca bottone con chiunque, Ateniesi o stranieri, ricchi o poveri, poeti o sacerdoti, fabbri o pittori, e li sfinisce a parlar con loro di cosa siano la bellezza, la giustizia, la perizia tecnica e tutte queste cose qua. In città lo chiamano “il tafano”, e il commediografo Aristofane, il meglio del meglio nel suo settore, lo ha inserito una commedia intitolata Le Nuvole... non proprio lusinghiera: il “Socrate personaggio” di Aristofane dimostra a un ragazzo che è giusto maltrattare i genitori e spendere tutto alle corse dei cavalli, e gli amici che chiacchierano con Socrate, a quanto pare, sono dei matti in culo che si fanno sollevare con le carrucole per scoprire di cosa son fatte le nuvole.
Già, gli amici di Socrate. Si dà il caso che Socrate sia stato amico e confidente di Alcibiade figlio di Clinia, il generale che durante la guerra ha vandalizzato le statue portafortuna del dio Hermes, e piuttosto che andare a processo è scappato... a combattere per Sparta. E come se non bastasse, frequentava pure Crizia il Giovane figlio di Callescro, il capo supremo dei Trenta Tiranni. E poi, ovviamente, c'è il giovane Senofonte figlio di Grillo, che aveva partecipato al massacro degli Eleusini sotto il comando di Crizia; casualmente Senofonte è irreperibile, scappato in Persia, e si dice che gliel'abbia consigliato Socrate stesso. Ah e non scordiamoci di Aristocle figlio di Aristone, quello che fa pugilato ed è soprannominato Platone, “Spallone”: è pronipote di Crizia, e la mela non cade lontana dall'albero.
Per cui, vi pare che la democrazia ateniese, ripristinata dopo tanti anni di dolore, possa tollerare Socrate a piede libero, questo ideologo del partito aristocratico? Ovviamente no, per cui ecco che un simpatizzante democratico cita in giudizio il signor Tafano:
«[...] questo ha sottoscritto e giurato Meleto di Meleto, Pitteo, contro Socrate di Sofronisco, Alopecense. “Socrate è colpevole di non riconoscere come Dei quelli tradizionali della città, ma di introdurre Divinità nuove; ed è anche colpevole di corrompere i giovani. Pena: la morte”.»
Un processo un po' sconclusionato
Parole pesanti come una lancia pesante, ed ecco che Socrate, il nullatenente logorroico, si deve preparare a processo. Ma qui iniziano le cose strane.
Per la legge ateniese, l'imputato deve esporre personalmente il suo discorso di auto-difesa, quella che in Ateniese si chiamava apologia, e la professione di avvocato consisteva proprio nello scrivere il discorso e preparare il cliente (infatti “avvocato” si diceva logografo = scrittore di discorsi). In questo momento, il logografo più bravo di Atene è Lisia figlio di Cefalo, nato ad Atene ma di famiglia immigrata da Siracusa: Lisia non è cittadino ateniese, è “solo” uno straniero residente con, diremmo oggi, permesso di soggiorno lavorativo, e per il regime dei Trenta Tiranni questo era grasso che colava: non solo gli hanno confiscato i beni e costretto a fuggire a Megara (città allegramente alleata con Sparta), ma gli hanno pure ammazzato il fratello Polemarco. Ora Lisia è sul piede di guerra contro i superstiti del regime e vuole giustizia per sé e la sua famiglia, e infatti si offre volontario per comporre l'arringa di accusa contro Socrate... Aspettate, no! È l'esatto contrario! Lisia si offre di difendere Socrate, ed è il signor Tafano che cordialmente declina e si prende la responsabilità di fare da sé.
E le sorprese non finiscono qui. Perché Socrate inizia la sua apologia con un bel riepilogo dei propri meriti come onesto cittadino: durante la guerra, dopo il suo servizio militare ineccepibile, il Tafano di Atene è stato sorteggiato per partecipare al comitato che, diremmo oggi, detiene collettivamente la presidenza della repubblica, e durante il suo mandato (siamo nel 406 a.C.) la flotta ateniese aveva sconfitto clamorosamente quella spartana alle isole Arginuse... ma gli ammiragli non erano riusciti a soccorrere i marinai naufragati, e per questo il popolo li voleva morti. Per tutto il suo mandato, Socrate bloccò il procedimento con tutte le proprie forze, non poté ovviamente impedire che il suo successore lo avviasse, e così gli ammiragli vennero giustiziati... e Atene perse la guerra.
Ma non solo: saltiamo avanti di qualche anno, al 404 a.C., durante le purghe dei Trenta Tiranni. Crizia e i suoi lacché vogliono desaparire Leonte di Salamina, un immigrato benestante (proprio come la famiglia di Lisia), bisogna comporre la squadraccia della morte, ed esigono che partecipi anche Socrate (chissà se per la parlantina sciola o per le manone da scultore): il signor Tafano non riesce a salvare Leonte, ma si rifiuta di servire nella polizia politica, e per questo avrebbero fatto fuori anche lui... se i democratici nazionalisti non avessero sconfitto il regime.
Un quadro ben strano, gente: Socrate era amico di Alcibiade, il disertore, ma ha cercato di salvare gli Ateniesi dalla propria stessa dabbenaggine; si è rivoltato contro la tirannia di Crizia, eppure ha aiutato Senofonte a fuggire in esilio; e durante il processo, a parteggiare per lui, ci sono tanto Lisia quanto Aristone detto Platone. Dove sta la coerenza di quest'uomo?
Incominciò con un demone a posto
L'Apologia di Socrate ci è stata tramandata in due versioni: quella trascritta da Platone è considerata una delle prose più belle composte in Greco Antico (anche da me medesimo), quella trascritta da Senofonte non se la fila nessuno (e neppure io l'ho mai letta, ma dovrei), per cui mi soffermerò sul nodo centrale del resoconto platonico.
Socrate prende di petto l'accusa contro di lui, e nega fortemente sia la presunta empietà sia la presunta cattiva influenza sulla gioventù. Anzi, costruisce una catena argomentativa che demolisce dalle fondamenta tutto il teorema accusatorio (che paroloni, mi sento un giornalista di cronaca):
1. Tutto parte dalla curiosità di Cherefonte, amico storico di Socrate, che anni addietro è andato nella città di Delfi per interrogare l'oraclo del dio Apollo e scoprire se davvero l'amico Socrate eccelle fra gli Ateniesi. L'oracolo delfico era sempre ben disposto a paracularsi (vedasi nel 550 a.C. circa, quando gli chiesero chi avrebbe vinto la guerra fra gli imperi di Persia e di Lidia e rispose “Un grande impero cadrà”. Grazie tante...), ma stavolta, stranamente, rispose senza ambiguità: sì, Socrate primeggia fra gli Ateniesi per virtù morale e intellettuale.
2. A complicare le cose, da che ne ha memoria, Socrate ha particolare devozione verso quello che, da Greco antico, chiamava “demone”: un essere sovrannaturale che non è fisico e mortale, a differenza di piante e animali e umani, ma non è nemmeno potente e imperituro quanto gli dèi del cielo del mare e del sottosuolo, e si potrebbe equiparare, quindi, alle ninfe femminee che, per l'appunto, animano e vegliano gli alberi e le sorgenti e le spiagge. Perché questo demone, da sempre, veglia su Socrate, e davanti a una decisione lo ammonisce, lo stuzzica e lo trattiene perché si astenga dalla via disonesta.
3. Forte del demone che lo accompagna, Socrate decide di sondare la correttezza del verdetto di Apollo, e inizia a interrogare uno a uno tutti gli Ateniesi e tutti gli stranieri che incrocia, confidando che prima o poi troverà certamente qualcuno migliore di lui... ma così non accade. Perché il buon Socrate, ogni singola volta, constata uno di due casi: i lavoratori che padroneggiano un mestiere tecnico si persuadono che tutti gli altri saperi siano concettualmente subordinati alla propria professione, e pertanto si arrogano a priori la padronanza di tutto lo scibile umano; i benestanti che hanno avuto una formazione umanistica finalizzata all'attività politica (un po' di diritto, un po' di belle lettere, un po' di scienze della comunicazione) non conoscono assolutamente niente di significativo, ma sono meramente capaci di ammaliare e intortare l'interlocutore per convincerlo di sapere tutto. E in entrambi i casi, sia i tecnici sia i letterati non possono resistere alla metodologia demolitrice di Socrate: a furia di chiedere “Che cos'è?”, “Che cosa ne consegue?” e “Ma ipotizziamo il suo contrario...”, il signor Tafano li manda in crisi e in bestia, e a quel punto ci sono altri due casi: chi se ne va via offeso ed esasperato, e chi si appassiona a questo modo di ragionare e diventa amico di Socrate, per cercare di partorire assieme una verità più solida e profonda di quella che insegnano i cosidetti sofisti (da cui il nostro “sofisticare”): i professoroni di saperi umanistici che, per lo più, sono stranieri immigrati ad Atene per fare fortuna parassitando i benestanti.
Ed ecco che il resoconto di Platone si intreccia con i Ricordi della vita di Socrate raccolti da Senofonte: ricordi in cui Senofonte mette bene in chiaro, sin da subito, che nella sua ricerca Socrate puntava a individuare, nei saperi tecnici, la massima efficienza attraverso il giusto sforzo, tanto nella costruzione di un portico quanto nell'addestramento di un cavallo; che nelle questioni etiche perseguiva la conciliazione e la concordia, ad esempio quando mediava le liti fra la moglie e i figli; e che sia Alcibiade sia Crizia frequentavano Socrate nella speranza di apprendere da lui la sua inconfondibile perizia retorica, da riciclare in politica per assicurarsi consenso e prestigio... e ambedue si allontanarono dal Tafano, allorché questi mise in chiaro che non c'era trippa per gatti. E a questa caterva di testimonianze aggiungiamo, già che ci siamo, anche l'incipit dell'Anabasi (sarebbe a dire “Viaggio di andata e ritorno”. No, non è una traduzione de Lo Hobbit), il diario degli anni di esilio che Senofonte trascorse da mercenario nell'impero di Persia: egli mette in chiaro che Socrate non gli consigliò esplicitamente di espatriare, ma lo invitò a consultare l'oracolo di Delfi (aridaje) e il responso fu palese.
Insomma, abbiamo ampi elementi per ipotizzare che Socrate rappresentasse una verruca sui glutei sia per i nazionalisti democratici sia per gli aristocratici filospartani, e che, per paradosso, nel suo giro di amici convivessero le menti migliori di ambo gli schieramenti, più tanta altra gente non propriamente schierata: Senofonte afferma che Socrate nutrisse stima reciproca per Aspasia di Mileto, concubina del generale Pericle (l'artefice degli anni d'oro dell'impero ateniese), mentre Platone racconta di un'istruzione spirituale impartita a Socrate da Diotima di Mantinea, misteriosa sacerdotessa e mistica che, forse, non è mai esistita, ma se fosse esistita sarebbe non solo donna straniera (come Aspasia), ma pure nativa di un territorio filospartano. E se vi par poco che Socrate, forse, fosse amico di donne colte, considerate che la segregazione di genere praticata ad Atene aveva poco da invidiare alla misoginia delle peggiori teocrazie cristiane e musulmane di oggi.
Per cui, ricchi ateniesi, dotti forestieri, concubine e sacerdotesse, pugili e mercenari: questi gli amici di Socrate, e a tenerli assieme, a quanto pare, c'era un atteggiamento anti-dogmatico rispetto all'istruzione tradizionale, oltre che un certo rispetto verso la voce del demone, l'esperienza spirituale che animava l'indole del Tafano.
«Ergh, cretinodicrescenzago, perdonami, ma io ero qui per un discorso sull'accountability: se mi interessava la storia greca cercavo una puntata a tema nei podcast di Barbero...»
Ci sto arrivando, giuro che adesso ci arrivo.
Che tutto continui in fiumi di dubbio
Il processo, Socrate lo perse. Fu giudicato colpevole di stretta misura, come da prassi gli fu richiesto di proporre lui una pena alternativa, e come atto di spregio richiese la pensione vitalizia in ricompensa a un servizio pubblico eroico, al che lo condannarono a morte invitandolo, fra le righe, a fuggire in esilio (di nuovo, come da prassi)... e fu così che il signor Tafano accettò di farsi incarcerare, rifiutò il piano di evasione ed esilio proposto dai suoi amici più cari, e il giorno stabilito fu giustiziato assumendo veleno di cicuta.
I suoi discepoli si sparsero ai quattro venti, e nei decenni successivi costruirono tutte le grandi scuole di pensiero della filosofia greca: cinismo, platonismi (al plurale, perché Platone ebbe un bel numero di discepoli creativi), aristotelismo (ecco, Aristotele era il più volpone dei platonici), epicureismo, stoicismo, scetticismo. Insomma, tutte quelle dottrine scientifiche, etiche, politiche e teologiche che nei secoli successivi si sarebbero ibridate direttamente con i saperi dell'Egitto faraonico e del Vicino Oriente semita (e, indirettamente, con suggestioni iraniche e addirittura indiane), andando a costituire la visione di mondo delle èlite europee per il successivo millennio e mezzo.
E qui, gente, ecco arrivare il mio punto
E meno male...
Alla base della cultura pan-occidentale, c'è un uomo fortemente religioso che ha riconosciuto dentro di sé un bisogno profondo e irresistibile, e ha dedicato tutta la sua vita a perseguirlo: ore, giorni, settimane e mesi di chiacchiere con altre persone per condividere con loro che domandarsi “Che cos'è?” vale infinitamente di più del memorizzare “È fatto così e cosà”; innumerevoli scelte di vita analizzate nell'ottica di identificare il punto intermedio virtuoso tra due possibili estremi viziosi, in accordo con il motto “Mai troppo” esposto sul tempio di Apollo a Delfi; innumerevoli situazioni in cui quel punto intermedio virtuoso ha significato deporre le proprie certezze (“So di non sapere”, diceva il Tafano) e riunciare a ciò che sembrava comodo in favore di ciò che risultava profondamente giusto, e non a caso Socrate ha rinunciato prima alla benestanza e poi alla vita, perché un'esistenza senza dibattito e senza ricerca, per come era fatto lui, sarebbe stata indegna di essere vissuta (e infatti l'altro motto delfico recitava “Conosci te stesso”).
Indagare le cose anziché ripetere a pappagallo; indagare assieme anziché in solipsismo; perseguire la curiosità anziché il bigottismo; restare fedele a un senso morale profondo, potenzialmente divino, a scapito dell'opportunismo egocentrico. Sono tutte pratiche di vita che l'Occidente tecnocratico ha allegramente polverizzato nel tritacarne dello scientismo e dell'autocrazia, ma che in un tempo lontano sono state alla base del pensiero pagano di lingua greca, quel pensiero che avrebbe incontrato il pragmatismo curioso dei popoli italici a Ovest e la grande tradizione magica egizia, siriaca e mesopotamica a Est, e da tutto questo calderone sarebbe scaturito quel cristianesimo che ha consegnato alla storia sia la violenza dispotica di Papi e imperatori sia le “guerre sante dei pezzenti”, dai moti contadini del Milleduecento fino alla teologia della liberazione latinoamericana. E del resto, c'è un certo consenso storiografico attorno alla tesi che il falegname Yeshua bar Ioseph da Nazareth fosse, a conti fatti, un rabbino-lavoratore di provincia aderente alla corrente più democratica del monoteismo giudaico, e a un certo momento abbia mollato tutto e iniziato a girare per la Palestina predicando una morale di mutualismo concreto e di resistenza pacifica all'occupazione romana... finché non è stato arrestato e giustiziato come bestemmiatore della fede giudaica e ribelle al potere legittimo.
Vi ricorda un certo scultore greco?
Di domande restiamo pienu
Insomma, credo abbiate capito il mio punto: possiamo raccontarci tutte le storielle di psicologia spicciola possibili rispetto al concetto di accountability, ma, a mio giudizio, ciò che ci vuole è un passo indietro, fino a quell'epoca in cui il Mediterraneo era ancora un punto di intreccio fra Europa, Africa e Asia, e noi Europei non l'avevamo ancora trasformato irrimediabilmente nella frontiera cimiteriale fra il “nostro” mondo civile e la barbarie “altrui”. Facendo questo passo indietro, ci accorgiamo che un ragionamento sull'analisi profonda dei propri valori e delle proprie azioni era già ben presente nelle nostre culture, e aveva una connotazione spirituale che francamente trovo molto salutare, a fronte di una mentalità materialista “delle evidenze e dei fatti” che ha prodotto non già una laicità di convivenza pacifica fra materialistu, spiritualu e scetticu (ciascun gruppo con le sue declinazioni infinite), bensì l'equazione dicotomica “ateismo : civiltà : bianchezza = religione : barbarie : popoli colorati”.
Facendo questo passo indietro, quando avevo 16 anni e stavo ascoltando la prima lezione di filosofia in terza superiore, io stesso ho imparato che fa bene, ogni tanto, togliersi di proposito il terreno sotto i piedi e scoprire cosa c'era sotto, ed estraniarsi da sé quel tanto che basta da chiedersi “Che cosa sto facendo? Dove voglio andare?”... e stare in silenzio abbastanza a lungo da udire la vocina del demone, che ci bisbiglia quello che davvero sentiamo sia giusto e necessario.
Si suol dire che la modernità colonialista occidentale è iniziata allorché René Descartes ha teorizzato la separazione netta fra la materia inerte e il pensiero razionale, bollando come falsa qualunque prospettiva filosofica altra proveniente dai popoli indigeni dell'Asia, dell'Africa e delle Americhe (tertium non datur, avrebbe scritto lui), e in tal sede Descartes si avvalse dell'immagine di un “genio maligno” da aggirare per approdare alla sua verità. Se davvero l'Occidente cartesiano non ci piace, forse forse per smontarlo e rimontarlo meglio vale la pena di togliere la maschera al genio maligno e restituirgli la sua identità originaria di demone socratico, che ci accompagni nella ricerca infinita di una Verità che non è mai data una volta per tutte.
E a questo proposito, sarebbe molto opportuno fare spazio sull'altarino dedicato al demone e riscoprire anche le dottrine della sacerdotessa Diotima sulla funzione cosmica ed etica dell'amore, o ancora di più coinvolgere nel nostro dialogo socratico anche la povera Santippe, cui nessuno ha mai chiesto com'è stato vivere con un marito che manteneva lei e i tre figlioli con le elemosine degli amici e ha reputato più giusto morire, lasciandoli in miseria, piuttosto che rifarsi una vita altrove tutt'assieme. Io non sono un necromante abbastanza abile da evocare lo spirito di Santippe e dialogare con lei, e chiederle “Cos'è la libertà, per chi non esce di casa?” oppure “Cos'è la giustizia, per chi non può lavorare?”, ma sono piuttosto certo che il mondo sia pieno di Santippi da coinvolgere nei nostri discorsi: alcune di loro si chiamano Angela Yvonne Davis, Sakîne “Sara” Cansiz, Marielle Franco o Gloria Evangelina Anzaldúa, altre sono “las compas marchando en Reforma [...] las morras peleando en Sonora [...] las Comandantas luchando por Chiapas [...] las madres buscando en Tijuana”, altre ancora probabilmente mi state leggendo adesso (e ve ne sono grato).
Per cui, gente, facciamolo assieme questo passo all'indietro, e facciamolo tuttu.
Comincio io, che un Tafano non lo sono, però sono un cretino:
“Cosa vuol dire, secondo te, comunità?”
Appendice bibliografica
Per chi, giustamente, non vuole prendere per oro colato la mia lezioncina di storia, procuratevi e datevi una lettura a queste fonti primarie o quasi primarie:
1. Aristofane, Le nuvole.
2. Platone, I Tetralogia composta da Eutifrone, Apologia di Socrate, Critone e Fedone. Più il Simposio dalla III Tetralogia.
3. Senofonte, Memorabili (traduzione convenzionale e stupida dell'originale “Ricordi”), Apologia di Socrate. Più, volendo l'Anabasi e le Elleniche (traduzione convenzionale aulica dell'originale “Storia della Grecia”).
4. Tucidide, La Guerra del Peloponneso.
5. Diogene Laerzio, capitolo su Socrate nelle Vite e dottrine dei filosofi illustri.
6. Schalom Ben-Chorin, Fratello Gesù. Un punto di vista ebraico sul Nazareno